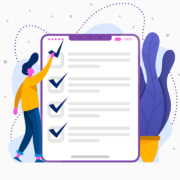Tag Archivio per: coronavirus
Ecco perché il Coronavirus non può essere (sempre) infortunio sul lavoro
/in Circolari, Sicurezza sul lavoroL’origine professionale del contagio deve essere provata, non presunta. Di responsabilità non si dovrebbe neppure iniziare a discutere, se manca la prova del contagio sul lavoro.
1. L’infezione da Coronavirus come malattia-infortunio
E’ la legge, e non INAIL, ad avere introdotto la qualificazione della infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2) come infortunio sul lavoro; ma certo INAIL ci ha messo del suo.
L’art. 42 della legge n. 27/2020 (conversione del D.L. n. 18/2020) è noto: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.
Ciò garantisce al contagiato le prestazioni INAIL “anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro”.
La norma si basa sulla nozione giuridico-dottrinaria di “malattia-infortunio”, fondata sulla equiparazione della causa virulenta alla causa violenta. Posto che ciò che distingue l’infortunio sul lavoro dalla malattia professionale non è la conseguenza per la persona, bensì la modalità con cui opera l’agente causale (notoriamente l’infortunio si qualifica per la “causa violenta”, la malattia invece per una azione prolungata nel tempo), utilizzando il criterio della causa virulenta da tempo l’ordinamento ha dato tutela alle malattie infettivo-parassitarie attraverso il loro inquadramento assicurativo nella categoria degli infortuni.
Per il contagio da COVID-19, la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 interpretativa dell’art. 42 ha dunque fatto applicazione dell’indirizzo INAIL in materia di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare INAIL n. 74 del 23 novembre 1995: “la causa virulenta è equiparata a quella violenta”.
Di qui, l’affermazione per cui la infezione da Coronavirus è infortunio; ma naturalmente, per essere infortunio “sul lavoro” e quindi indennizzabile INAIL, deve essere provata la causa di lavoro.
2. Il problema della prova della origine professionale: la presunzione semplice
Qual è il momento contagiante? Come può dimostrarsi che l’infezione è stata contratta per causa di lavoro?
E’ su questo punto, che la Circolare INAIL n. 13 introduce le regole che tanta preoccupazione stanno determinando in tutti coloro i quali operano nei luoghi di lavoro con una posizione di garanzia (il datore di lavoro, ma certo non solo lui).
Ciò che l’art. 42 richiede, in quanto indispensabile per qualificare un infortunio come “sul lavoro”, è che il caso di infezione da Coronavirus sia “accertato” come contratto “in occasione di lavoro”.
Sulla definizione di occasione di lavoro, la Circolare INAIL n. 13 richiama “tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore”.
Ma può esservi contagio in occasione di lavoro, se il rischio di contagio costituisce un rischio generico?
Nel sistema di assicurazione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n. 1124/1965 – non dimentichiamoci che l’art. 42 della legge n. 27/2020 si intitola “Disposizioni INAIL” – “rischio generico” è quello che non ha relazione con l’attività lavorativa e professionale ma grava in maniera uguale e indiscriminata su tutti i cittadini, lavoratori e non. Esso non è oggetto di copertura assicurativa INAIL. Quindi, una persona che contrae l’infezione per un contatto avvenuto per la strada o in qualsiasi momento della sua vita privata non ha diritto a tutela, indipendentemente dal fatto che si tratti di un lavoratore (cioè di soggetto rientrante nella categoria dei soggetti tutelati dal Testo Unico INAIL) oppure no.
La persona del lavoratore è tutelata quando l’infezione è contratta per una esposizione ad un “rischio specifico”, se cioè il rischio di contagio ha una relazione causale diretta con l’attività lavorativa esercitata. E’ il principio in forza del quale il camionista o l’autista del bus è tutelato per i rischi della circolazione stradale: per quei lavoratori si tratta di rischi lavorativi a tutti gli effetti.
Una ulteriore specificazione riguarda le ipotesi del “rischio generico aggravato”, cioè i casi in cui un rischio è astrattamente generico, ma è aggravato da particolari fatti o circostanze che lo ricollegano all’attività lavorativa svolta al punto da far ritenere il lavoratore come meritevole di tutela assicurativa.
In situazioni di questo tipo, la giurisprudenza ha elaborato in passato il principio della “Presunzione Semplice d’Origine”: la prova di un contagio di supposta origine professionale, sebbene non dimostrata, può ritenersi presunta in presenza di gravi, precisi e concordanti elementi.
Sviluppato ad esempio per rischi professionali di infezione da Epatiti o AIDS, il principio ha trovato applicazione da parte di INAIL ritenendo l’origine professionale per soggetti esposti per motivi professionali al contatto con sangue e sperma: chirurghi, infermieri addetti a prelievi di sangue, personale addetto a manipolazione di sangue o sperma per accertamenti di laboratorio.
3. Contatti con i malati, contatto con il luogo, contatti con il pubblico/l’utenza: tre diversi casi di presunzione semplice.
Ebbene, nel caso della pandemia, la Circolare 13 afferma che gli operatori sanitari sono “esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus”.
Questo non dovrebbe significare che per tutti gli operatori sanitari contagiati si verte in ipotesi di infortunio; l’Istituto dovrebbe comunque compiere una propria indagine finalizzata a verificare, ad esempio, la compatibilità temporale del periodo di incubazione, il contatto con un soggetto in condizioni tali da trasmettere il contagio, ma anche la esclusione di comportamenti extraprofessionali “a rischio”.
Senonchè, la Circolare INAIL n. 13 prosegue oltre, nella sua applicazione della presunzione semplice:
“A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari”.
L’ambito di applicazione dello strumento presuntivo si allarga di molto.
INAIL di fatto tratta allo stesso modo, ai fini probatori (anzi, presuntivi) il contatto con i malati o i casi sospetti di Coronavirus (sono i soggetti “a rischio” con i quali vengono a contatto per lavoro gli operatori sanitari) e il contatto con il pubblico/l’utenza (cioè le persone “comuni” con le quali vengono a contatto per lavoro gli addetti alle vendite, front-office, ecc.); INAIL tratta allo stesso modo anche i contatti non con le persone, ma con il luogo in cui le persone infette sono in qualche modo presenti o anche solo transitate, o con “le cose” che ivi si trovano (è il caso del personale non sanitario degli ospedali).
E’ evidente che si pone un problema legato al fondamento scientifico di questa equiparazione, ad esempio in tema di modalità di circolazione e trasmissione del virus, ma non è certo il nostro tema.
Quello che possiamo osservare, sul piano normativo, è invece che tra il DPCM 11 marzo 2020 e il DPCM 17 maggio 2020 esiste un abisso, in punto di presunzione di contagio da contatto: il divieto quasi assoluto di contatto diretto tra le persone allora introdotto è stato ora di fatto eliminato dal legislatore, sostituito da una regola di segno contrario secondo cui è possibile muoversi liberamente, salve talune circostanze particolari.
E’ ancora possibile affermare in questo mutato contesto – ammesso che lo fosse prima – che il contatto con l’utenza è fattore di rischio, o meglio di “aggravamento del rischio” rispetto al rischio generico di contagio?
Inoltre, quanto contano i comportamenti extraprofessionali, i contatti del lavoratore fuori dell’orario di lavoro, i contatti dei suoi familiari, congiunti, amici, conoscenti, di tutti coloro che possono ora essere liberamente frequentati?
La discussione naturalmente è aperta; ma ci sembra che proprio questo sia un punto fondamentale, e cioè rimuovere la convinzione che la Circolare INAIL (una circolare anch’essa, alla fine) abbia detto una parola definitiva; a maggior ragione ove si considerino le circostanze assolutamente – quelle sì – emergenziali in cui fu emanata.
4. I lavoratori fuori della presunzione semplice, cioè tutti gli altri.
Cosa accade invece per tutte le altre categorie di lavoratori?
La Circolare INAIL si occupa anche di loro:
“Residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
In sostanza, INAIL non afferma che ogni caso di contagio di un lavoratore è infortunio sul lavoro; afferma esattamente il contrario, e cioè che l’infezione diventa tale solo se è dimostrato che è tale.
INAIL afferma che ognuno di questi casi deve essere affrontato singolarmente e fatto oggetto di specifica istruttoria; in altre parole, ogni volta che un lavoratore contrae l’infezione, deve verificarsi: 1) se è noto e/o se viene provato l’episodio che ha determinato il contagio, oppure 2) se ci sono elementi presuntivi legati alla specifica fattispecie oppure 3) se l’accertamento medico-legale conduce ad affermare la natura “lavorativa” del contagio. Se nessuno di questi casi si configura, l’infezione non potrà essere trattata come infortunio sul lavoro; si tratterà di ordinaria malattia.
Tutto secondo i principi, allora?
Dipende da come le tre circostanze vengono intese; dipende se e quanto uso si farà di presunzioni; dipende da come verrà gestita la “’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale”.
Quello che il datore di lavoro può e deve temere, ad esempio, è che si finisca per includere, tra le circostanze “privilegiate”, le eventuali violazioni rilevate nel luogo di lavoro delle regole di contenimento del contagio.
Sarebbe profondamente sbagliato: la violazione della regola cautelare di prevenzione rileva ai fini della colpa, per imputare al datore di lavoro la responsabilità di un contagio; ma una tale affermazione di responsabilità richiede prima, appunto, la prova che quel contagio è avvenuto in azienda.
Però questa “necessità” di prova non emerge, dall’art. 42; anzi, quello che da esso è derivato è l’obbligo di redigere la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro, per il solo fatto che il contagiato è un lavoratore e solo per questo motivo.
Non si tratta, si badi, di negare la tutela assicurativa ai contagiati in occasione di lavoro; si tratta di interrogarsi sull’uso dello strumento presuntivo.
Quello che appare poco condivisibile, della norma, è che essa sembra ignorare il dato di fondo sul piano scientifico e tecnico, e cioè la mancanza di qualsiasi certezza che consenta di dare un minimo di contenuto concreto alla parola chiave dell’art. 42: infezione “accertata…in occasione di lavoro”.
Si dà per scontato, nella formulazione della norma, che sia infortunio sul lavoro soltanto la infezione “accertata”, e questo è corretto; ma non si è voluto fare i conti con i rischi di una applicazione impropria per ovviare le difficoltà di questo accertamento.
La Circolare n. 13, dal canto suo, verosimilmente nel lodevole intento di dare tutela ai lavoratori più coinvolti nella fase violenta dell’epidemia, ha applicato in maniera lapidaria e perentoria un sistema di presunzioni semplici che probabilmente avrebbe meritato ben altro studio del caso concreto, e che sicuramente oggi richiede una profonda riflessione e probabilmente una rivisitazione.
Insomma, oggi si parla molto di responsabilità e giustamente si critica l’art. 42 per questo: ma prima ancora di discutere il tema della responsabilità civile e penale del datore di lavoro, ci sembra che sia da mettere in discussione la tesi che ne è presupposto, e cioè la natura stessa del contagio come infortunio.
E’ la premessa che va innanzitutto cambiata; è la deroga all’onere della prova sull’origine professionale, la distorsione che per prima va combattuta.
5. INAIL ha davvero escluso la responsabilità del datore di lavoro?
Gli interventi di questi giorni di INAIL (il comunicato stampa del 15 maggio 2020 che ricorda gli oneri probatori in sede civile e penale per aversi responsabilità del datore di lavoro; l’intervista del Presidente ad un quotidiano) sono senz’altro apprezzabili, nel loro intento di dire una parola di tranquillità; ma forse suscitano proprio l’effetto contrario. Perché se INAIL parla di responsabilità, anche se per metterla in dubbio, vuol dire che già siamo in un contesto di infortunio sul lavoro.
Nulla dice INAIL, invece, per rettificare il tiro sull’utilizzo della presunzione semplice in maniera massiva; né detta direttive precise, rigorose e stringenti sui criteri di accertamento dell’origine professionale.
Se la ragione di questo silenzio è la mancanza di certezze scientifiche sufficienti, è più una preoccupazione che una consolazione.
In realtà, INAIL avrebbe potuto valorizzare, nel dibattito in corso, ciò che l’art. 42 dispone espressamente, e cioè che gli eventi infortunistici di cui si discute “non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico” dell’azienda. Questa precisazione dovrebbe confermare la natura mutualistica dell’art. 42, e che la scelta del legislatore è stata quella di assicurare tutela ai contagiati ma al tempo stesso di non addebitare le relative conseguenze economiche al datore di lavoro, evidentemente per l’impossibilità di imputare a lui la responsabilità del contagio.
Però nessuna voce si è udita da INAIL in questo senso; anzi ed al contrario, non appare infondato il timore che proprio la necessità di recuperare gli oneri di questa tutela estesa possa un domani giustificare l’esercizio di azioni di regresso dell’Istituto verso i datori di lavoro, previa contestazione di una ritenuta responsabilità di rilevanza penale. Contestazione rispetto alla quale certamente non gioverà, al datore di lavoro, “la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro”: nonostante il comunicato stampa INAIL mostri sul punto una sorprendente diversa opinione.
Webinar 7 maggio ore 16 | Sicurezza del lavoro nella FASE 2: il Protocollo Aziendale Anti Contagio
/in Convegni, Sicurezza sul lavoroCosa deve contenere il Protocollo Anti Contagio dell’impresa? Come deve essere adottato?
Quali sono le attenzioni particolari da avere? Quale la disciplina INAIL, e quali le implicazioni assicurative?
Ne parliamo nel webinar gratuito di giovedì 7 maggio 2020 ore 16.00-18.00.
Per iscriverti, clicca qui
Dati di localizzazione, tracciamento dei contatti e Covid-19: le linee guida dell’EDPB
/in Circolari, PrivacyL’utilizzo di app per il tracciamento dei contatti sociali (c.d. contact tracing) pone necessariamente una serie di aspetti problematici in materia di privacy e protezione dei dati personali. Il monitoraggio sistematico e su larga scala dell’ubicazione e o dei contatti tra persone fisiche costituisce infatti una grave interferenza nella sfera della vita privata dell’individuo.
Ad oggi, in assenza di provvedimenti del Legislatore, il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19, con l’ordinanza n. 10/2020, ha disposto di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso e di appalto di servizi gratuito con la società creatrice dell’app “Immuni”, prescelta dal Governo. Nell’ordinanza si afferma che il contact tracing è ritenuto un elemento importante all’interno di una strategia sostenibile post-emergenza per un ritorno alla normalità, in quanto tecnologia in grado di rilevare il tracciamento di prossimità in modo molto più efficiente e rapido rispetto a quello tradizionale.
Lo scorso 21 aprile il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito EDPB) è intervenuto adottando le Linee-guida 04/2020 sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al COVID-19.
Lo scopo di queste linee guida è solamente quello di fornire dei chiarimenti sulle condizioni e sui principi per un uso proporzionato dei dati di localizzazione e degli strumenti di tracciamento. Il quadro normativo in questo ambito è infatti già rappresentato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dalla Direttiva 2002/58/CE (Direttiva E-privacy) che di per sé consentono di gestire efficacemente tutti gli aspetti relativi alla privacy a fronte alla pandemia in corso.
Con riguardo all’utilizzo dei dati relativi all’ubicazione, l’EDPB ne individua due principali fonti: quelli raccolti da fornitori di servizi di comunicazione elettronica nel corso della prestazione del servizio (come gli operatori di telecomunicazioni mobili), e quelli relativi all’ubicazione raccolti da fornitori di servizi della società dell’informazione la cui funzionalità richiede l’uso di tali dati (ad es: servizi di navigazione).
Questi dati possono essere trattati solo entro i limiti di cui agli artt. 6 e 9 della direttiva 2002/58/CE; ciò significa che il fornitore potrà comunicarli alle autorità o a terzi solo se siano stati resi anonimi ovvero, per il caso in cui non siano dati relativi al traffico, subordinatamente alla raccolta del consenso dell’utente.
L’archiviazione di queste informazioni, ai sensi dell’art. 5 della sopracitata direttiva, può poi avvenire solo se l’utente ha prestato il consenso, ai sensi degli artt. 4 e 7 del GDPR, oppure solo se la memorizzazione e/o l’accesso sono strettamente necessari al servizio esplicitamente richiesto dall’utente.
In ogni caso nelle linee guida in analisi si evidenzia come dovrebbe essere privilegiato il trattamento dei dati relativi all’ubicazione in forma anonimizzata. L’anonimizzazione consente infatti di utilizzare i dati senza limitazioni, eliminando la possibilità di collegarli ad una persona fisica identificata o identificabile con uno sforzo “ragionevole”.
Con riguardo alle app per il tracciamento dei contatti, il loro utilizzo, secondo l’EDPB, può essere legittimato solamente sulla base di un’adozione volontaria da parte degli utenti. Ciò comporta che coloro che non intendano o non possano utilizzare tali applicazioni non debbano subire alcun pregiudizio.
La realizzazione di applicazioni per il tracciamento dei contatti deve poi fondarsi sui principi di responsabilizzazione, di limitazione delle finalità di trattamento, di minimizzazione, di protezione dei dati fin dalla progettazione e di limitazione della conservazione dei dati. In applicazione di questi principi le app non dovrebbero comportare il tracciamento della posizione dei singoli utenti, bensì utilizzare le informazioni di prossimità relative agli utenti stessi. Queste informazioni, che devono essere pertinenti e strettamente necessarie, dovrebbero poi risiedere nell’apparecchiatura terminale dell’utente. Il trattamento delle informazioni così raccolte non necessita del consenso dell’utente esclusivamente laddove le operazioni di trattamento siano necessarie per consentire al fornitore dell’app di rendere il servizio esplicitamente richiesto.
L’utilizzo delle app di tracciamento può poi comportare il trattamento di dati personali relativi alla salute che come tali sono soggetti alle particolari garanzie contenute nell’art. 9 del GDPR. Il Comitato in proposito ricorda che il trattamento dei dati relativi alla salute è consentito quando è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (art. 9, co. II, lett. i) del GDPR) o per le finalità dell’assistenza sanitaria (art. 9, co. II, lett. h) GDPR).
In conclusione, l’EDPB chiarisce che l’attuale crisi sanitaria non dovrebbe trasformarsi in un’occasione per derogare al principio di limitazione della conservazione dei dati. La conservazione infatti dovrebbe essere limitata alla luce delle reali esigenze e della rilevanza medica dei dati personali, i quali dovrebbero essere conservati solo per la durata della crisi dovuta al COVID-19, ed al cui termine dovrebbero essere cancellati o resi anonimi.
Coronavirus, il Protocollo delle Parti Sociali per gli ambienti di lavoro
/in Sicurezza sul lavoroLe attività lavorative non si fermano, ma le regole diventano più stringenti.
Prime istruzioni operative per il datore di lavoro
Governo e Parti Sociali hanno sottoscritto un “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Cambia qualcosa per i datori di lavoro che hanno deciso di proseguire l’attività?
Proviamo a rispondere, tracciando un primo quadro delle novità.
La normativa di riferimento. Il Protocollo è vincolante per tutti?
Il documento è stato discusso tra le Parti Sociali “su invito” del Governo, in attuazione del DPCM 11 marzo 2020 il cui art. 1 comma primo n. 9 raccomanda e favorisce “intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.
Tra le due opzioni in discussione, se adottare un Codice di autoregolamentazione volontario o un Protocollo vincolante, la scelta è caduta su quest’ultima.
La questione ulteriore, se il Protocollo abbia natura vincolante anche per quanti non aderiscono alle Organizzazioni sindacali firmatarie, non viene affrontata qui non solo per ragioni di brevità e di argomento, ma anche perché ben difficilmente un datore di lavoro potrebbe giustificare la mancata applicazione delle misure ivi previste con l’argomento della loro applicabilità formale.
Il presupposto del Protocollo è che “La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione”; il Protocollo è strumento che viene adottato “rapidamente” perché questo consente di raggiungere, appunto in tempi rapidi, quello che viene definito come “obiettivo prioritario”, e cioè “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”.
Che tutti indistintamente – al di fuori in realtà di una qualsiasi riflessione sulla natura giuridica del documento e sulla sua genesi – mostrino di considerare il Protocollo alla stregua di un atto normativo, è un dato di fatto che non si può ignorare, in una logica di concretezza operativa.
Il quadro minimo di regole obbligatorie per poter proseguire l’attività d’impresa, dunque, non è più costituito soltanto dall’art. 1 numeri 7-9-10 del DPCM 11 marzo 2020 (integrato delle misure igienico-sanitarie), ma deve ritenersi ora integrato dalle previsioni del Protocollo.
La conclusione che se ne trae (in concreto, cioè al netto di ogni disquisizione giuridica che la situazione emergenziale travolge) è che l’applicazione del Protocollo è obbligatoria e vincolante per ogni datore di lavoro che prosegue l’attività.
Peraltro, come si vedrà, molte delle misure del Protocollo rimandano all’esercizio del potere datoriale di valutare condizioni e presupposti specifici della propria organizzazione.
Le misure del Protocollo e le misure aziendali “integrative”
Un altro aspetto che va segnalato riguarda la natura “generale” delle prescrizioni contenute nel Protocollo, il quale invita le aziende ad integrarle “con altre ritenute equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione”.
Si delinea così una gerarchia di misure (DPCM-Protocollo-Piano Aziendale), sulle quali vale la pena sottolineare come alcune di esse siano sostanzialmente misure dirette, perentorie, direttamente applicabili senza necessità di valutazione alcuna, mentre molte altre presuppongono una discrezionalità del datore di lavoro, da esercitare nell’ambito di alcuni limiti prestabiliti.
Tra questi limiti, oltre ai criteri generali finalizzati al contenimento del contagio (distanza minima, divieto di assembramenti, ecc.), il Protocollo ne introduce uno rilevante di natura procedimentale, quello del confronto sindacale.
Si prevede infatti il “confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali…affinchè ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST”.
Il Protocollo peraltro che tale confronto “va favorito” in una logica di “consultazione”: sicchè l’azione datoriale non appare vincolata, ai sensi del Protocollo, alla necessità di una decisione condivisa e ad un formale assenso delle rappresentanze dei lavoratori.
Le novità più rilevanti del Protocollo
a)
Alcune delle misure previste nel Protocollo ripropongono, e magari razionalizzano, regole oramai già acquisite dalle organizzazioni in ottica di prevenzione del contagio; su tutte, vige trasversale la regola della distanza di sicurezza di un metro tra le persone (derogabile solo in casi eccezionali e con rigorose prescrizioni).
Così è, ad esempio, per il paragrafo 1 dedicato alla “Informazione” sul contagio e sulle regole di condotta in caso di sintomi, all’impiego di cartelli, avvisi, depliants informativi; per il paragrafo 5 dedicato alle “Precauzioni Igieniche Personali”; per il paragrafo 9 dedicato alla “Gestione Entrata e Uscita dei Dipendenti”.
b)
Alcuni paragrafi affrontano temi già noti, introducendo però alcune regole specifiche che per il datore di lavoro si traducono in “obblighi di fare” direttamente verificabili.
Così è ad esempio per il paragrafo 3 dedicato alle “Modalità di Accesso dei Fornitori Esterni”: vanno individuate procedure di ingresso, transito e uscita; non è consentito “per nessun motivo” l’accesso agli uffici degli autisti, che anzi devono rimanere a bordo dei mezzi; vanno individuati/installati per gli esterni servizi igienici dedicati.
Per il paragrafo 4, “Pulizia e Sanificazione in Azienda”, l’azienda deve assicurare pulizia giornaliera e sanificazione periodica di luoghi e postazioni; pulizia a fine turno e sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, sia negli uffici che nei reparti produttivi.
Per il paragrafo 7, “Gestione degli Spazi Comuni (Mensa, Spogliatoi, Aree Fumatori, Distributori di Bevande e/o Snack) vanno contingentati gli accessi, ventilati in continuo i locali, ridotti i tempi di sosta all’interno; vanno puliti giornalmente e sanificati periodicamente i locali mensa e le tastiere dei distributori di bevande e snack; gli spazi e gli spogliatoi vanno organizzati e sanificati per lasciare luoghi disponibili per il deposito degli indumenti di lavoro.
Per il paragrafo 10, “Spostamenti Interni, Riunioni, Eventi Interni e Formazione”, vanno adottate indicazioni aziendali per limitare al minimo gli spostamenti interni, mentre le riunioni in presenza non sono consentite se non per necessità ed urgenza in caso di impossibilità di collegamento a distanza e comunque con partecipazione al minimo e rispetto del distanziamento interpersonale e pulizia/aerazione dei locali; tutti gli eventi interni vanno sospesi e annullati.
Sono tutte misure di rilevante impatto dal punto di vista economico, organizzativo e della gestione di processi e persone.
c)
Una novità significativa riguarda il Paragrafo 2, “Modalità di Ingresso in Azienda”.
Il Protocollo ripropone una misura, il controllo della temperatura corporea, che la prassi aveva in qualche misura introdotto nelle scorse settimane ma si era poi ridotta anche in ragione dell’intervento del Garante della Privacy con il provvedimento di segno contrario del 2 marzo 2020.
Viene previsto che il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo (da chi, non è specificato) e per colui al quale la misura risulterà superiore ai 37,5°, sarà interdetto l’accesso ai luoghi di lavoro, sarà isolato “momentaneamente”, fornito di mascherine; è vietato che si rechi al Pronto Soccorso, ma anche alla infermeria di sede, e dovrà contattare il proprio medico curante.
La rilevazione della temperatura non è un obbligo, ma soltanto una facoltà: sicchè non appare sindacabile la decisione del datore di lavoro che decidesse di non provvedervi. La clausola del Protocollo appare finalizzata più a dare legittimità ad una condotta che taluni avevano adottato, ma per la quale mancava un supporto normativo di liceità, piuttosto che ad introdurre un obbligo (sempre che si ritenga sufficiente un Protocollo sindacale a tali fini, ma questo è un altro discorso). Considerata la pervasività della misura, appare del resto ragionevole, in una logica di bilanciamento di interessi, una decisione di non applicare il controllo, anche perché non appare più di tanto risolutiva dal punto di vista prevenzionale. La prova, che non si possa imputare ad un datore di lavoro una negligenza omissiva per non avervi provveduto, sta da ultimo nel fatto che è una misura che nessun provvedimento del Governo ha mai introdotto in nessuna fase dell’emergenza, neanche in quella più acuta.
Vero è per contro che il datore di lavoro che vi provveda deve gestire l’adempimento con la massima attenzione ai profili di trattamento dei dati personali, sui quali lo stesso Protocollo fornisce le proprie indicazioni suggerendo di non registrare nessun dato, se non quando l’esito sia positivo con conseguente diniego di accesso (si apre qui un complesso capitolo anche probatorio, nella prospettiva di contestazioni del lavoratore), di fornire (anche oralmente: ma poi chi lo dimostrerà?) una informativa sintetica ma mirata sul trattamento al soggetto interessato, che a questo punto sarà soltanto un soggetto con febbre, di definire le misure di sicurezza del trattamento istruendo adeguatamente gli incaricati al trattamento, e infine di assicurare riservatezza anche nell’isolamento momentaneo.
Naturalmente, se si attua questa misura occorrerà organizzare tutti i comportamenti che ne derivano in caso di superamento del limite di temperatura, predisponendo struttura e personale ad hoc.
L’altra misura conosciuta nel recente passato e che il Protocollo ripropone, seppure in via indiretta, è di richiedere al lavoratore (o all’esterno) una dichiarazione attestante che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con positivi o che non proviene da zone a rischio.
In realtà, l’unico obbligo previsto per il datore di lavoro è, anche in questo caso, di informare ogni persona che entra in azienda della preclusione all’accesso per chi si trova in tali condizioni: anche questo è un obbligo informativo già noto alle aziende, tanto più rilevante in quanto ad esso corrisponde l’obbligo di leale collaborazione del lavoratore, o del soggetto esterno, come lavoratori ma anche come cittadini.
L’ipotesi di richiedere specifica dichiarazione è trattato invece in una nota a pie’ pagina del Protocollo, introdotta da un “qualora” che, ancora una volta, sembra avere lo scopo di rendere lecita questa richiesta di dichiarazione, piuttosto che imporne al datore di lavoro l’obbligo.
Quindi, anche in questo caso il datore di lavoro sarà senz’altro ed a maggior ragione libero di non richiedere alcunchè (se lo farà, ancora una volta dovrà gestirne ogni aspetto ivi comprese le cautele nel trattamento dei dati); ma anche i limiti alla tipologia di dati che secondo il Protocollo il datore di lavoro può chiedere sono tali (ovviamente) che questo tutto appare tranne che un reale strumento di prevenzione. E questo, aldilà della difficoltà di comprendere il significato della richiesta ad un lavoratore di dichiarare di non provenire da zone a rischio epidemiologico, in un contesto come quello italiano attuale (che non ha più “zone”) che non è certo più quello dei giorni in cui questa prassi era invalsa in talune zone. Non a caso, il Protocollo richiama qui l’art. 1 lettera i) del D.L. n. 6/2020, in cui il tema era “l’ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico”.
I Dispositivi di Protezione Individuale
Come è naturale, il Paragrafo 6 dedicato ai DPI è uno dei punti centrali del Protocollo.
Esso dichiara che l’adozione dei DPI è “fondamentale”, ma significativamente sottolinea anche che la loro adozione, “vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio”.
Per questo motivo, si impone di utilizzare le mascherine “in conformità” alle indicazioni dell’OMS; il che significa, se ben si intende, farne un uso appropriato anche dal punto di vista tecnico-sanitario, e non invece un uso massivo ed indifferenziato: la “mascherina per tutti” sembra, secondo questa regola, non solo un obbligo che non esiste, ma anche una misura poco raccomandabile perchè riduce il numero di mascherine disponibili quando davvero necessarie (a meno che, ma in questo momento non è così, vi sia sovrabbondanza di mascherine da distribuire).
Ancora, si ammette che il datore di lavoro in caso di difficoltà di approvvigionamento utilizzi “mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria”: anche qui, sembra doversi intendere che siano dichiarate utilizzabili anche mascherine tecnicamente non a norma, ad esempio perché non marcate CE: ma è necessaria l’indicazione dell’autorità sanitaria, e quindi a queste indicazioni occorrerà rifarsi per poter utilizzare mascherine di questo tipo.
Fino a che le indicazioni non ci sono, occorre evitare l’impiego di mascherine non conformi (sarebbe errato pensare che una “qualsiasi” mascherina va bene purchè ci sia, perché comunque si alza il livello di protezione: anzi si ingenera nelle persone la errata convinzione che il dispositivo assolva alla sua funzione protettiva quando magari non è così).
Anche per il liquido detergente viene introdotto un “fai da te”, favorendo la preparazione di esso “da parte dell’azienda” seguendo le indicazioni dell’OMS per le quali si rimanda addirittura ad uno specifico link.
Se si afferma che le mascherine non vanno usate sempre e comunque in azienda, e che possono essere anche mascherine “non CE” ma solo se “abilitate” dall’autorità sanitaria, rimane fermo un principio già sancito nettamente dall’art. 1 n. 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020: la distanza interpersonale deve essere sempre di almeno un metro, e solo quando il lavoro “imponga” una distanza minore, e quando “non siano possibili altre soluzioni organizzative”, allora “è comunque necessario l’uso” non solo delle mascherine, ma di tutti i dispositivi di protezione individuale: “guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.)”.
Prima di prevedere di utilizzare i DPI, dunque, occorre compiere alcuni passaggi ben precisi, nella valutazione della postazione di lavoro, considerando non solo gli aspetti tecnici ma anche ogni possibile soluzione organizzativa: la compresenza dei lavoratori, intendendo per tale la distanza tra di essi inferiore ad un metro, deve costituire una ipotesi necessitata e non altrimenti risolvibile.
E’ il caso di osservare che il tenore letterale utilizzato è più stringente di quello dello stesso DPCM, che imponeva l’uso di DPI laddove non fosse possibile rispettare la distanza “come principale misura di contenimento”.
In conclusione sul punto, la mediazione che il Protocollo ha trovato tra necessità di impiego dei DPI e difficoltà di approvvigionamento di essi sembra potersi sintetizzare in questo modo.
In uno scenario di rispetto della distanza interpersonale minima: se i DPI sono disponibili senza problemi, si potrà farne uso anche solo come misura precauzionale, però in conformità delle indicazioni dell’OMS (quindi non a casaccio: se ce ne sono poche, meglio non farne uso dove non serve); se non sono disponibili quelle pienamente certificate, è ammissibile fare ricorso a modelli disponibili solo se consentiti dall’autorità sanitaria; se serve liquido detergente, si può anche ricorrere al “fai da te” purchè secondo la regola.
Quello della distanza interpersonale minima è lo scenario che il datore di lavoro deve puntare a raggiungere, con qualsiasi mezzo possibile ivi comprese misure organizzative.
Ma quando, e solo quando, la distanza minima non sia raggiungibile, allora non ci sono opzioni alternative, e l’impiego dei DPI deve essere assoluto: DPI che dovranno anche in questo caso essere quelli “conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.
Ne consegue che, se la distanza interpersonale non c’è e i DPI non sono disponibili, la lavorazione non può essere eseguita e l’attività deve essere sospesa.
Prosecuzione sì, ma largo anche alle altre opzioni
Rispetto al DPCM 11 marzo 2020 che “raccomandava” la sospensione delle attività non indispensabili, il massimo utilizzo del lavoro agile, l’incentivazione delle ferie, ma senza dare indicazioni specifiche e lasciando al datore di lavoro le valutazioni del caso, il Protocollo non cambia l’impostazione di fondo, ma ne individua alcuni criteri direttivi, per così dire.
Nel Paragrafo 8, dedicato alla “Organizzazione Aziendale (Turnazione, Trasferte e Smart Work, Rimodulazione dei Livelli Produttivi)”, si legge che le imprese “potranno” intervenire sulla organizzazione.
Vi si legge anche che potranno farlo “avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali”.
A questo riguardo, il Paragrafo 13, “Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione”, prevede che venga costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Come è normale che sia, questo è l’ambito nel quale potrà assumere massimo significato il confronto sindacale citato nella Premessa del Protocollo; e questo già influisce sul potere datoriale di organizzazione, anche solo dal punto di vista procedimentale.
Criteri di natura più sostanziali si trovano poi nel Protocollo.
Andrà esaminata la possibilità di chiudere i reparti “diversi dalla produzione” (cioè tutti quelli che produzione non sono: il DPCM parlava di “attività non indispensabili alla produzione”) o comunque di quelli che possono funzionare con smart work o a distanza. Ancora una volta, peraltro, la “possibilità di funzionamento del reparto” significa non già una praticabilità del lavoro agile in astratto, bensì la sua fattibilità in concreto sulla base delle oggettive condizioni aziendali esistenti (non esiste, in altre parole, un obbligo del datore di lavoro di attivare lo smart working in ogni reparto non produttivo, se non ci sono le condizioni di fatto).
Per i dipendenti dedicati alla produzione (esclusi per definizione dal lavoro agile) andrà valutata la turnazione, con due obiettivi ben indicati: diminuire al massimo i contatti, e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
Viene prevista la rimodulazione dei livelli produttivi.
Vengono poi menzionati gli ammortizzatori sociali “in via prioritaria” e gli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) che consentono l’astensione dal lavoro senza perdita di retribuzione.
Vanno utilizzati i periodi di ferie, specificando che si sta parlando di quelli “arretrati e non ancora fruiti”.
In generale, il Protocollo conferma il presupposto di fondo, e cioè che la sospensione delle attività è una opzione: ma tale rimane, e non certo un obbligo, sicuramente per i reparti produttivi ma anche per quelli, diversi, che potrebbero operare in modalità agile.
E’ fin troppo ovvio osservare, peraltro, che questa parte del Protocollo è quella sulla quale maggiormente influiranno, ai fini delle scelte dell’imprenditore ed anche nella prospettiva del confronto sindacale, le misure di carattere economico disposte dal Governo.
Formazione e Sorveglianza sanitaria
Nell’ambito della sospensione di tutti gli eventi e di ogni attività di formazione, il Protocollo sancisce che il mancato aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti non comporta l’impossibilità di svolgere i ruoli e le funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, cui la formazione è finalizzata: l’addetto all’emergenza potrà continuare ad intervenire, il carrellista potrà continuare a condurre il carrello.
La disposizione ha una sua logica nel contesto emergenziale, anzi è da considerare senz’altro apprezzabile, anche perché non pare davvero che ne derivi una reale diminuzione di tutela per chicchessia (tanto più quanto più il periodo di sospensione sarà breve, come tutti ci auguriamo).
Però.
Innanzitutto, viene da domandarsi se le Parti Sociali siano i soggetti legittimati a questo tipo di “legittimazione in deroga”; una disposizione simile è stata emessa ad esempio dalla Regione Veneto, ma si tratta con tutta evidenza di soggetto con ben altro ruolo e competenza istituzionale sulla materia.
Ragionando per analogia, dovremmo ritenere che ad esempio gli Ordini Professionali possano sancire la deroga all’aggiornamento della formazione per gli iscritti che ricoprono ruoli e funzioni in ambito di sicurezza e salute del lavoro.
Lascia inoltre perplessi un altro dato: ciò che secondo il Protocollo rende lecito sospendere la formazione (cioè uno dei cardini del sistema di sicurezza del lavoro) in quanto “causa di forza maggiore”, e cioè “l’emergenza in corso”, non rende invece lecito sospendere la sorveglianza sanitaria.
Anche in questo caso, che siano le Parti Sociali a decidere cosa deve o non deve fare il Medico Competente, lascia quantomeno perplessi; e infatti può dubitarsi del fatto, che i Medici Competenti siano davvero tenuti a dare seguito al Protocollo là dove prescrive perentoriamente non solo che non può esserci sospensione, ma anzi addirittura che la sorveglianza sanitaria “deve” proseguire.
Non appare più di tanto convincente la motivazione addotta, cioè che la sorveglianza sanitaria sia essa stessa misura di prevenzione del contagio perché il Medico Competente “può intercettare possibili casi e sintomi”, e “per l’informazione e formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori”.
Quest’ultima potrà ben essere impartita a distanza, a tutto concedere; che poi un contatto ravvicinato tra lavoratore e Medico Competente, anziché essere considerato per quello che è, e cioè una occasione di contagio, venga considerato addirittura come un momento di rilevamento dello stesso, non sembra davvero in linea con il principio generale che vuole nella assenza di contatto tra le persone il primo e fondamentale baluardo contro la diffusione del virus, e nella riduzione degli spostamenti del lavoratore (che invece sarà chiamato a recarsi a visita, non necessariamente in azienda) un’altra regola basilare.
Né appare possibile giustificare tale parte del Protocollo con la tutela del lavoratore, posto che la questione riguarda le visite periodiche, adempimenti di cui lo stesso Decreto 81 ammette la gestione della periodicità, e posto che proprio il lavoratore da visitare finisce per venire esposto ad un rischio aggiuntivo di contagio.
Dopodichè, la visita medica dovrà essere svolta certo non soltanto rispettando il decalogo ministeriale dettato per la popolazione (come si legge nel Protocollo), bensì con le massime cautele di natura igienico-sanitaria (limitazione degli accessi, sanificazione dell’ambiente, attrezzamento per il distanziamento delle persone, eventuali sistemi di separazione tra medico e lavoratore visitato, ecc.): tutti adempimenti che comportano per il datore di lavoro un impegno di natura organizzativa, tecnica ed anche economica, che non appaiono giustificati da un contrapposto interesse corrispondente.
Appare invece condivisibile il richiamo alla collaborazione del Medico Competente con il datore di lavoro e con il RLS (non viene citato il RSPP) “nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19”: anzi, viene da osservare che forse proprio l’emergenza in atto sta portando alla luce l’importanza della collaborazione tra datore di lavoro e Medico Competente, non più relegato soltanto alla funzione della “visita”; questa funzione di collaborazione alle misure probabilmente avrebbe meritato nel Protocollo una attenzione maggiore.
Conclusioni
Volendo formulare una prima valutazione del Protocollo, in attesa di sue implementazioni e della sua attuazione anche a livello aziendale, l’impressione che se ne può ricavare è che l’impostazione di fondo data dai provvedimenti del Governo non ne esca intaccata; né poteva essere diversamente.
La liceità della prosecuzione dell’esercizio delle attività produttive ne esce non solo confermata, ma anzi rafforzata dall’imprimatur, per così dire, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; a nessun datore di lavoro potrà dunque essere contestato alcunchè, dal punto di vista della tutela dei lavoratori dell’azienda, per il fatto di avere continuato l’attività anziché disporne la sospensione.
Questo vale per i reparti produttivi, ma anche per tutti gli altri, di cui non viene sancito un obbligo di chiusura.
Se questo è vero, va però anche sottolineato che le maglie delle regole, che consentono l’esercizio dell’attività, si vanno facendo via via sempre più strette; inoltre, le disposizioni limitative si vanno facendo più numerose, più frastagliate, e sempre più condizionate alle specifiche condizioni di ciascuna singola realtà produttiva.
Occorre che il datore di lavoro dedichi attenzione, molta attenzione, alle condizioni in cui l’attività viene fatta proseguire: questo è ciò che il Protocollo comporta.
Il datore di lavoro deve muoversi su due livelli: il primo è quello di base, delle regole uguali per tutti (e sono essenzialmente quelle legate ai profili igienico-sanitari in senso stretto); il secondo è quello delle misure organizzative (dei luoghi di lavoro, dei processi aziendali, delle singole lavorazioni) legate alla specifica realtà aziendale, che vanno di pari passo con le scelte di fondo di natura strategica, economica, aziendale in senso lato (legate anche ai provvedimenti economici del Governo).
Studio Legale Casella e Scudier

INFO
Ultime news
Contatti
Via Lucatello, 6 – 35121 Padova (PD)
Tel: 049 876 66 89
Tel: 049 876 65 78
Fax: 049 821 93 60
E-mail: segreteria@casellascudier.it